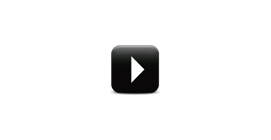Umberto Eco. Un ricordo di Lo Piparo, un'intervista a Regazzoni
di Marco Marino
Inizia il nostro viaggio attorno alla figura di Umberto Eco e all'interno delle pagine del suo capolavoro, Il nome della rosa (Bompiani), che in queste settimane arriva sugli schermi televisivi per una serie tv su Rai1 ideata e diretta da Giacomo Battiato.
Ci sono figure del nostro tempo che si sono imposte sul nostro immaginario come icone, cui aggrapparsi per permetterci di dire che è ancora possibile fondare nuovi miti, trovare dei modelli da seguire. Non sono molte, sembra essersi spenta la cultura dei maestri, ma Umberto Eco sicuramente è una di queste. Il suo nome è diventato sinonimo di intelligenza enciclopedica: tutti lo ricordano passeggiare fra le stanze di casa sua, ricolme di libri, un numero di volumi che sembrava infinito e suscitava quella spontanea domanda a cui Eco rispondeva sempre con ironia beffarda:
«Ma li ha proprio letti tutti?».
«Molti di più, signore, molti di più!».
Serissimo professore universitario e fine dicitore di barzellette. Autore del Trattato di semiotica generale e dell'analisi filologica di Tre civette sul comò. Un uomo che studiava la cultura medievale, portando sotto la camicia la maglia di Superman. Per parlare di Eco, della sua intelligenza e dei suoi paradossi, per cercare di inoltrarci dentro l'universo de Il nome della rosa, oggi abbiamo l'occasione di confrontarci con due suoi profondi conoscitori: Franco Lo Piparo, professore emerito dell'Università di Palermo, già docente di Filosofia del Linguaggio, nonché amico di Eco; e Simone Regazzoni, allievo di Jacques Derrida, filosofo e scrittore, autore del saggio Iperomanzo (Il Nuovo Melangolo, 2018), in cui dedica diversi capitoli allo studio de Il nome della rosa.
Un ricordo di Franco Lo Piparo
Ho conosciuto Umberto Eco all’inizio degli anni Settanta tramite Tullio De Mauro. Col passare degli anni diventammo amici personali. Con mio piacevole stupore ho costatato che sovente venivo invitato, Eco suggeritore, là dove non mi aspettavo di essere invitato.
L’ultima volta lo incontrai a Bologna nel giugno del 2015. L’occasione fu un dibattito sui quarant’anni del Trattato di semiotica generale. Ci lasciò sette mesi dopo.
Aveva una dote rarissima che non so dire che con l’espressione «riso intellettuale». Il riso intellettuale è un modo di stare nel mondo che è il contrario del fanatismo e del fondamentalismo. Il riso intellettuale si esercita anzitutto verso se stessi. Chi ride intellettualmente sa che il mondo potrebbe essere diverso da come ce lo rappresentiamo e questa possibilità la sperimenta con la battuta di spirito, l’ironia, il gioco di parole. Forse l’intera opera di Eco potrebbe essere letta a partire dal «riso intellettuale». Sul riso ruota il romanzo che lo renderà popolare in tutto il mondo, Il nome della rosa.
A proposito del suo riso intellettuale racconto un episodio che mi riguarda.
Nel gennaio del 1995 mi invitò a tenere una lezione all’Università di San Marino di cui dirigeva la sezione umanistica. Dopo una breve presentazione Eco andò a sedersi tra il pubblico. Come mi capita quando ad ascoltarmi c’è qualcuno al cui giudizio tengo particolarmente, per tutto il tempo lo tenni d’occhio. Lo vidi sempre curvo su fogli di carta e con la penna in mano. Quel comportamento mi incuriosì molto. Elaborai due ipotesi. 1) Sto dicendo cose così interessanti da spingere Umberto a prendere appunti dettagliati. La mia immodestia però non osava arrivare a tanto. Dirottai verso una spiegazione più realistica. 2) Approfitta di questo tempo morto per scrivere l’articolo che settimanalmente pubblica su L’Espresso. Finita la lezione, Eco mi pose delle domande molto circostanziate. Segno che era stato attento a quello che avevo detto. Neanche la seconda ipotesi funzionava bene.
La sera, mentre siamo sulla strada per il ristorante, Eco tira fuori dalla borsa una cartella di foglietti dove aveva trasformato in vignette umoristiche quello che avevo detto a lezione. Me ne fece dono. Ne riproduco qui alcune. L’argomento della lezione (Il gioco del comprendere e del non comprendere come fonte di suggerimenti teorici) può aiutare a capire meglio il senso delle immagini.
***
Un'intervista a Simone Regazzoni
Nel suo saggio Iperomanzo scrive che «nei romanzi di Eco, a partire da Il nome della rosa, si traccia un percorso di straordinaria potenza filosofica ancora tutto da leggere»: com'è possibile che un thriller come Il nome della rosa, dal successo mondiale, possa avere anche un'enorme forza filosofica? Solitamente sono due elementi, la popolarità e la filosofia, che fra di loro stridono.
Solo un’idea accademica della filosofia può concepire la filosofia come discorso riservato a un’élite di presunti esperti: in realtà, questa è la riduzione della filosofia a gergo e la sua morte come esperienza di pensiero. In particolare, oggi, questo è il destino della filosofia analitica, ridotta a un gioco autoreferenziale per una cerchia ristretta di professionisti del pensiero. Eco, che pur era un accademico e un uomo di smisurata cultura, sapeva bene che, fin dall’origine, la filosofia si è misurata con il problema della propria circolazione nello spazio pubblico. Platone, ad esempio, usa i Sokratikoi logoi ('i dialoghi socratici') per far circolare il proprio pensiero, inserendosi in una tradizione letteraria già esistente e portandola a un livello artistico più alto in cui Nietzsche vedrà una forma di romanzo. L’operazione di Eco eredita il meglio della tradizione filosofica e la rilancia nell’epoca della cultura di massa con una mossa geniale: sceglie una forma romanzo considerata bassa, paraletteraria, il giallo, per mettere in atto un’operazione di contaminazione tra filosofia e letteratura che di solito fa pensare a Dostoevskij non a Conan Doyle. In realtà Eco sa bene che già Dostoevskij aveva contaminato narrazione d’appendice, avventure criminali e filosofia, come aveva ben visto Leonid Grossman nel suo studio sulla Poetica di Dostoevskij (Poetika Dostoevsko, Moskva 1925): «Combinare in un’unica creazione artistica le confessioni filosofiche e le avventure criminali, includere il dramma religioso nella trama del racconto d’appendice, condurre attraverso tutte le peripezie del romanzo d’avventure verso rivelazioni di un nuovo mistero – ecco quali compiti artistici si presentavano a Dostoevskij e lo chiamavano a un complesso lavoro creativo». Eco con il Nome della rosa crea una macchina per produrre interpretazioni: e nel 2019 noi siamo ancora qui a parlarne, a interrogarci sul suo significato e sui suoi effetti. Perché? Perché ha avuto la forza di ossessionarci. Come scriveva Eco nelle postille al suo romanzo: «Raggiungere un pubblico vasto e popolare i suoi sogni, significa forse oggi fare avanguardia e ci lascia ancora liberi di dire che popolare i sogni dei lettori non vuol dire necessariamente consolarli. Può voler dire ossessionarli».
Per lei, nella sua esperienza di filosofo-scrittore, qual è la maggiore eredità ricevuta dall'opera e dalla figura di Umberto Eco?
Non rinunciare a niente per fare filosofia: romanzo, fumetti, tv, cinema, senza preoccuparsi delle reazioni dei guardiani accademici. Ed essere consapevoli che la narrazione può spingersi al di là dei limiti della teoria. Come recita la bandella della prima edizione del Nome della rosa che custodisco gelosamente: «Di ciò che non si può teorizzare si deve narrare».