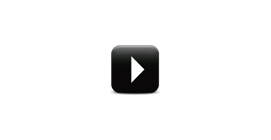I cento anni di Fellini. Tuena: "Regista unico ed ... europeo"
di Marco Marino
Basta sentire che qualcuno pronunci il suo nome per cominciare a evocare dentro di noi i titoli dei suoi capolavori, e subito dopo associarli alle situazioni che ci vedevano coinvolti mentre li vedevamo.
È come se fossimo consapevoli che in quel momento qualcosa stava cambiando, vedendo «La dolce vita» o «Amarcord» il sapore dei nostri ricordi è diventato più dolce, il nostro senso di possibilità smisurato: se a notte fonda Anita Ekberg, con un gattino in testa, ci avesse chiesto di trovare del latte, noi, come Marcello, il latte saremmo riusciti a trovarlo.
A cento anni dalla sua nascita, questo è l’incanto che Federico Fellini suscita senza età, a partire dai suoi contemporanei fino alla cosiddetta “Generazione Z”.
Nel giorno del tanto atteso centenario abbiamo voluto parlare di questo mito dei nostri giorni con lo scrittore Filippo Tuena che ha firmato un originalissimo scritto felliniano all’interno della nuova edizione di «Sul cinema» (il Saggiatore, 2019), il celebre libro-intervista di Fellini curato da Giovanni Grazzini.

Il cinema felliniano ha da sempre generato una sua mitologia, composta da elementi onirici, erotici, circensi. Mitologica è la figura del suo regista. Ma oggi cosa ne resta di quella mitologia? Di cosa si sostanzia?
Mi sembra che sia una mitologia oggi sterilizzata; messa in naftalina. Il termine ‘felliniano’ è entrato nel linguaggio comune e sta a indicare un pastiche di elementi che lei ha ricordato: onirici, erotici, circensi. Ma ormai ‘felliniano’ è un termine circoscritto alla sua opera. Nel corso degli anni ha ricevuto l’omaggio di autori di rilievo – «Stardust Memories» per esempio -, ma alla fine nessun regista, oltre all’omaggio circostanziato come quello di Allen, sembra aver tramandato la mitologia; non l’ha fatta propria. Per rimanere nell’ambito italiano del dopoguerra, si potrebbero enumerare decine di registi di primo piano che sono stati a lungo “neorealisti”. Non trovo un “felliniano” che vada oltre l’omaggio di un solo film. E poi, a quale Fellini dobbiamo riferirci? Quello che affronta l’autobiografia del presente – la crisi dell’autore – o che affronta l’autobiografia del passato – la vaporizzazione dei ricordi, il loro trasformarsi in elementi onirici? Ora, per fare un esempio, si usa a sproposito – riguardo agli ultimi film di Sorrentino – l’aggettivo felliniano. Sorrentino non mi sembra che faccia un cinema di memoria. Fa un cinema di immagini che per alcuni tratti può dirsi felliniano – si sappia però che non basta riprendere una processione di cardinali o ambientare una scena in un albergo termale per fare cinema felliniano. Fellini è molto più complesso di così.
Rileggendo la mia risposta mi sembra di poter aggiungere una postilla necessaria. Forse l’autore che ha lavorato sulla mitologia felliniana più di tutti gli altri mi sembra sia stato Bob Fosse. Il suo «All that jazz» è un film totalmente felliniano e regge ancora benissimo proprio nei punti più felliniani. E che dire delle prime immagini di «Cabaret»? Non è Fellini? Io penso di sì. Però ecco, anche lui è un contemporaneo di Fellini. Tra i nostri contemporanei c’è solo l’immenso equivoco di Sorrentino.
Qual è il suo legame con il cinema di Fellini?
Sono nato nel 1953 e credo che il primo film di Fellini che ho visto Fellini al cinema sia stato «8 ½», in un cinema d’essai di Roma. Mi fece una grande impressione. Poi ho seguito la normale trafila delle uscite cadenzate tra ripensamenti, film annunciati e film interrotti. (Nell’intervista il regista attribuisce queste indecisioni anche a fattori scaramantici. Non stento a crederlo che sia andata come dice).
Tutti gli uomini che sono stati quarantenni hanno due debiti importanti con autori che li hanno ritratti e analizzati. Il Fellini di «8 ½» e il Parise di «Sillabari». Direi che il climaterio maschile trova in loro i più compiuti interpreti.
Ho abitato a via Margutta a pochi palazzi dal suo. Incontravo più spesso la Masina, sempre con la sporta del mercato. Non abbiamo mai avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere come accade a vicini di casa, dunque il rapporto è esclusivamente quello col suo cinema, io spettatore lui suscitatore di immagini.
Come convive il cinema di Fellini con la letteratura? A volte sembra mimesi (penso al «Satyricon»), altre pura suggestione (come per «Il poema dei lunatici»). In «Sul cinema», parlando del film sulla Divina Commedia, Fellini è molto netto nel separare i due campi, eppure il suo immaginario è continuamente popolato dalla dimensione letteraria.
In quell’ibrida operazione che fu «Tre passi nel delirio» film a episodi di Vadim, Malle e Fellini, basato sui racconti di Poe l’unico prodotto di qualità letteraria è l’episodio diretto da Fellini, «Toby Dammit». È doppiamente letterario perché reinterpreta Poe e reinterpreta la mitologia felliniana facendo un’operazione che gli altri due registi coinvolti non riescono nemmeno a concepire. Del resto considerando gli inizi del «Marco Aurelio», le collaborazioni a film di Rossellini, su tutti, considerare Fellini un illetterato appare fuor di luogo. Certamente non fu accademico ma conosceva la letteratura molto bene e frequentava letterati tutt’altro che improvvisati. Le sue collaborazioni con Antonioni e Flaiano sono lì a dimostrarlo. Il suo tono sarcastico riguardo alla sua presunta ignoranza, non deve trarre in inganno. In entrambi i film prodotti da capolavori della letteratura, come il «Satyricon» e le «Memorie di Casanova» compare il cognome del regista, quasi a voler dimostrare l’intromissione anche decisiva nel testo originale. Operazione che non può farsi con un bagaglio culturale di seconda categoria.
Dal libro di Grazzini, che ritratto ne esce di Fellini intervistato?
Il libro è piacevolissimo perché Fellini è un conversatore piacevolissimo. Dovrei dire “monologante” eccellente. Il contraddittorio non gli si confà perfettamente e bravo è Grazzini a pungolarlo con poche, stringatissime domande e a lasciarlo andare a raccontare a briglia sciolta. In realtà poi Fellini non divaga perché come tutti gli affabulatori ci tiene molto a che il suo interlocutore – il lettore essenzialmente – rimanga soddisfatto della performance che mette in atto. E tiene anche a che l’intervistatore sia appagato nelle sue curiosità. Dunque risponde sempre a modo, salvo che si concede un buon margine di imprevedibilità. Da lì deriva l’interesse della lettura che è sì appagante proprio perché imprevedibile. Ne viene fuori un ritratto apparentemente ‘sincero’ se non negli esiti, nelle intenzioni. Piccole o grandi menzogne, piccole o grandi imprecisioni riguardo al passato artistico; piccole o grandi verità; piccole o grandi esattezze riguardo al presente. L’intervista si gioca tutta in questo immenso terreno di gioco. Nel momento in cui fa la sua comparsa nel discorso una situazione intrigante Fellini quasi la trasforma in una scena da film. Per far questo deve per forza modificare la realtà e adattarla al suo progetto. Del resto Fellini è un mistificatore affascinante. Non lo fosse stato avrebbe scelto Mastroianni come suo alter ego?
Giovanni Grazzini chiude la sua prefazione citando Milan Kundera: «negli ultimi decenni, dopo Stravinskij e Pirandello, dove trovare un’opera più bella, più possente nell’immaginazione? Dove trovare un’opera più importante, che, domanda su domanda, interroga tutto il destino europeo, le viscere stesse di quel destino?». Ma, secondo lei, alla domanda retorica di Kundera, la risposta può davvero essere l'opera di Fellini?
Ricordo che mi trovavo a Parigi per un soggiorno di studio quando uscì «Amarcord». Andai con un paio di amici nel cinema degli Champs Elisées dove lo proiettavano ed era effettivamente un evento. Fellini era un autore europeo; come spesso accade all’estero l’immagine di un’Italia provinciale risultava condivisibile; la Mille Miglia, il Rex, la nebbia della pianura Padana funzionavano come veicolo “comprensibile” anche ai francesi. Effettivamente era sì, un autore europeo. E internazionale. I cinque Oscar sono a dimostrarlo. Del resto chi aveva firmato «La dolce vita» o «8 e ½» poteva essere considerato un autore italiano? Ovvio che no. Rivolto la domanda: c’è qualche regista europeo che noi possiamo considerare europeo? Nessuno mi sembra possa essere paragonabile al Visconti di allora. I registi inglesi oggi sono inglesi, i francesi, francesi. Gli italiani, italiani. Forse sono i costi di produzione a trasformare il cinema degli anni ’60 da europeo che era a cinema nazionale.