Sciascia 2019. Giosuè Calaciura racconta il suo "Affaire Moro"
di Marco Marino
Dar vita a un racconto, prendendo spunto o evocando un titolo del suo storico catalogo. È questo l’esercizio letterario che l’editore Sellerio ha assegnato ad alcuni dei suoi migliori autori perché potessero essere realizzati i due volumi dell’antologia «Cinquanta in blu», uscita per celebrare il traguardo dei cinquant’anni della casa editrice panormita.
Impossibile pronunciare il nome di Sellerio senza citare Leonardo Sciascia, che dell’utopia letteraria di via Siracusa fu promotore e demiurgo. Infatti, un bonario spettro sciasciano aleggia all’interno di entrambi i libri, assumendo diverse forme a seconda della circostanza in cui si trova coinvolto. È il traduttore del «Procuratore della Giudea» che suggestiona la narrazione di Gaetano Savatteri; il prefatore della «Storia della colonna infame» da cui prende le mosse Maria Attanasio. Solo di un racconto, però, è diretto ispiratore con un suo pamphlet, «L’affaire Moro», e quel racconto in un aperto gioco di doppi si intitola appunto «L’Affaire Moro». Ma stavolta, a scriverlo, è Giosuè Calaciura.
Perché ha deciso di costruire il suo racconto attorno a «L’affaire Moro»?
Perché penso che «L’affaire Moro» sia il libro più preveggente di Leonardo Sciascia. È un saggio che intuisce con sorprendente luminosità i nodi delle contraddizioni e delle ambiguità del nostro paese. Ma non basta dire che è un saggio; è anche e soprattutto un romanzo sulla scrittura, sulla capacità di annodare i fili. È un libro fortemente letterario, a volte esclusivamente letterario.
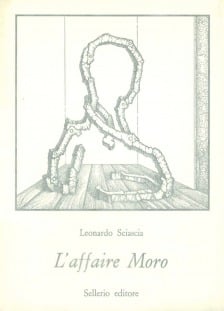
Fu un “instant book” ante litteram, uscito nell’autunno del Settantotto, pochi mesi dopo l’omicidio di Moro. Con che spirito lo lesse per la prima volta?
Ne fui davvero colpito. Oltre che un complesso momento storico, era per me anche un periodo particolare della mia vita: finiva l’adolescenza e cominciava l’età adulta. E il mio sogno di fare il giornalista era corroborato da questa capacità di racconto, di intuizione, di prosa di Leonardo Sciascia.
Cosa la colpì tanto?
Del libro mi colpirono maggiormente i suoi cascami. Non tanto il centro, ovvero la contrapposizione tra la Democrazia Cristiana e i cattolici veri che tentavano di salvare Moro. Ero affascinato da questi piccoli tasselli disseminati da Sciascia, che sfumavano il quadro generale. Tra questi c’era una notizia, assolutamente marginale, lasciata un po’ cadere lì, di un cittadino, non si sa bene chi, che durante il rapimento di Moro, estorce ottanta milioni a una banca dicendo di fare parte delle Brigate Rosse. Evidentemente non era delle Brigate Rosse…
Un evento alquanto paradossale.
Per Sciascia non c’era modo più efficace di questo inciso per descrivere il clima di terrore di quei giorni. In tutta la sua opera, la realtà è come se fosse imperniata attorno a una bugia, una mostruosità, una finzione. Pure in questo caso, gli basta lo spunto di una piccola bugia per raccontare le enormi contraddizioni italiane.

Ha mai avuto occasione di incontrarlo, Sciascia?
L’ho conosciuto grazie a mio padre, che era suo amico. E lo incontravo spesso seguendo mia madre nei vernissage, di cui Sciascia era un ghiotto fruitore. Poi lo frequentavo letterariamente, leggevo i suoi pezzi che uscivano sui giornali. Rimasi un po’ interdetto quando decise di scendere in campo, quella breve parentesi in cui cui si lasciò travolgere e convincere a partecipare in prima persona all’attività politica.
Per quale motivo?
Ritenevo che un uomo come Sciascia non potesse accettare “il teatrino della politica”. Era anche un modo per ribadire quanto fosse precisa in me l’immagine di Leonardo Sciascia come “intellettuale-contro”. Che aveva un suo pubblico, nonostante gli attacchi e le recensioni preventive dei più importanti giornalisti italiani: pensiamo a Montanelli, a Scalfari. Tanti hanno cercato di ostacolare la libera espressione del pensiero di Sciascia.
Era un uomo che sembrava avesse già capito tutto del corso delle cose. Dopo di lui, chi di noi riesce a pronunciare con innocenza la parola “antimafia”?
Infatti la vicenda Montante sembra un libro già scritto da Sciascia. Un perfetto capitolo dell’opera sciasciana, di quelli recitati peggio. Per questa sua peculiare capacità di visione, aveva un grande punto di riferimento, una luce, che era Luigi Pirandello.
Altro riferimento letterario molto presente nel suo racconto.
Nell’«Affaire Moro» Pirandello più volte viene menzionato e tirato in ballo. Mi è sembrato necessario, allora, sottolineare questa evidenza del ragionamento pirandelliano rispetto alla realtà siciliana e italiana. Nel racconto, cito apertamente una novella rivelatoria che lessi per la prima volta alle medie, «Il treno ha fischiato»: una di quelle storie che ti cambiano la vita, che ti dicono che esiste un’altra possibilità di raccontare il mondo, di uscire fuori dagli schemi, di essere comunque originali, di essere comunque contro. E quindi il mio lavoro prende ispirazione da Sciascia, ma vuole richiamarsi anche alle novelle di Pirandello.

Sono passati trent’anni dalla morte di Sciascia. E con lui sembra tramontata anche un’idea di intellettuale. Chi sono oggi gli intellettuali? Che ruolo hanno nella nostra società?
In questo ultimo periodo mi sono chiesto non a cosa serva oggi l’intellettuale, ma a cosa serva la sua opera. Che è ciò che ci interessa: a cosa servono i libri? Se dopo più di centocinquant’anni da Giovanni Verga, continuiamo disperatamente a raccontare le peripezie dei vinti, vuol dire che il ciclo dei vinti non si è mai concluso. Allora, mi chiedo, a cosa sono serviti centocinquant’anni di letteratura italiana se siamo ancora qui a raccontarci l’universo dei vinti, dei subalterni, degli emarginati? Come se un secolo e mezzo di letteratura fosse trascorso invano.
Eppure lei continua a scrivere.
Qualche giorno fa ho litigato con dei colleghi che mi dicevano: lo scrittore non deve avere vincoli, deve fare il suo mestiere e non deve in alcun modo essere messo alla prova e ricattato dalla realtà. Ho riflettuto a riguardo: sì, certo, hanno ragione; ma se sei uno scrittore che viene da Palermo, dalla Sicilia, dal Meridione, non puoi non avvertire la necessità di un risarcimento di giustizia per quelli che non hanno mai avuto né stampa né voce. Per i quartieri in cui non viene raccolta l’immondizia, che hanno l’acqua una volta ogni tanto; per i non privilegiati che alla vita partecipano per riflesso. Il minimo etico per uno scrittore siciliano è proprio non potersi esimere dal raccontare queste storie. Io purtroppo quando mi metto a scrivere mi viene una sorta di senso di colpa, perché provengo da una realtà che non ha giustizia. E quindi ritengo che sia per me quasi obbligatorio essere “engagé”. A questa realtà bisogna dare voce, tentare persino di farla diventare un universo poetico: il mondo dei vinti di oggi, degli esclusi: parlo del popolo della periferia, degli extracomunitari; parlo di quelli che non hanno nessun tipo di stampa e diritto. Che sono ancora tanti, sono la maggioranza, non ci illudiamo che sia diverso, che le cose siano già cambiate. Le cose stanno peggiorando sempre di più e sempre più spesso hanno poca stampa.










































