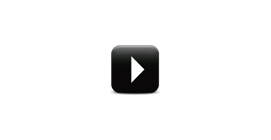"An elephant sitting still", uno dei più grandi film del secolo appena iniziato
di Marco Bagarella
E se volessimo passare questa domenica, con uno dei più grandi film del secolo appena iniziato? Se la vostra piccola/grande rubrica qui presente, si mettesse di primo acchitto in testa, di spaparanzarvi nelle iridi una nuova direzione di sguardo? Una pagina appena sfogliata nel grande atlante dell’immagine filmata? Ve la sentite, insomma, di prendere pericolosamente il largo con gli occhi?...
Sì, perché al mondo c’è di certo una geografia che sanguina. Il cinema di Hu Bo, visto, analizzato, commensurato e catalogato in cento modi diversi, forse può anche rientrare in questa strana ideografia cardinale. Cercherò di spiegarlo in brevi e – spero – chiare note.
“Quando Cristoforo Colombo si propose di attraversare gli ampi spazi vuoti all’ovest dell'Ecumene, aveva accettato di sfidare le leggende. Terribili tempeste avrebbero giocato con le loro navi, come gusci di noce, e li avrebbero gettati alla fine nella bocca di mostri; il grande serpente dei mari scuri, affamato di carne umana, era lì e stava in guardia”.
Così attacca, stando perfettamente nel pezzo, Edoardo Galeano nel racconto della scoperta/conquista delle Americhe; così mi viene di aprire questa riflessione, su un’opera cinematografica che può benissimo farsi risalire alla natura stessa del disvelamento di un ‘nuovo continente’. Una terra che stava lì, e non lo si sapeva. Un’emozione che sconvolge (come e quanto lo può un ‘prodotto dell’arte umana’), e che rasenta quella sensazione di contatto con un oggetto potente e fecondo e, in ugual modo, che fa della sua imperfezione un transert flessibile. A cui – per scherzo fragile o per serio amore – è poco possibile sfuggire.
E volendo continuare la similitudine, mi chiedo cosa mai può essere questo giovane animo orientale, al cospetto di un don Fernando Magellano; come può mai confrontarsi con un indomito esploratore che visse di ben quarantadue battaglie navali e quattro drammatici naufragi!
Eppure, l’aver fronteggiato uno scontro immane (quello tra delirio e verità), ed essere sparito tra i flutti di una tempesta senza appello (l’automorte, o suicidio, come vi vien meglio chiamare), immediatamente, posano sulle spalle cadaveriche del nostro regista, la livrea di ‘discopritore’ di territori selvatici, colono di coste apodittiche e inesauribile ambasciatore di piani-sequenza inviolati.
Ma di tutto questo appena detto, dovremmo, dobbiamo subito renderne conto.
Dopo aver rivisto per l’ennesima volta gli incredibili 236 minuti di questo film, ho il convincimento (sempre più manifesto) di poter congiungere le quattro storie che lo formano ed articolano, con le sorti (mai raccontate, almeno da ciò che la mia infinita ignoranza conosce), con gli eventi personali di quei marinai delle grandi giunche che nel 1400 – poco prima che l’Europa si prendesse per sé le Americhe e, con esse, il dominio del mondo intero – già tagliavano mari ed oceani. Sui galeoni delle maestà iberiche partivano spesso solo dei pazzi o degli assassini. Sulle navi cinesi che spinti dalle felici correnti marine del Kuro-Shivo, presto avrebbero toccato l’ovunqueterra, di certo molti disperati ed altrettanti illusi e innumerevoli affamati di se stessi, il posto lo avevano fin subito prenotato. Sulla zattera d’ombre e di luce di Hu Bo, un miracolo senza tempo ed un tempo filmico senza miracolo, salgono invece quattro antieroi e con la loro specie di presa di potere, noi non scopriamo terre ubertose ma una livida, lontana penisola di speranza.
E c’è una forma, c’è una sostanza. Anche una sola almeno.
Il regista usa un controcanto di scanzione del tempo (stacchi, intersezioni, allusioni periodiche), e di pedinamento dello spazio (lunghe riprese a mano che seguono, circondano, svelano, abbandonano gli sguardi e le parole degli attori), che riesce a tenere in bilico una continua sospensione del dramma.
Più lo sospende e lo acceca, più lo accentua e lo rende ipervedente; capace di penetrare le tenebre della narrazione e – perfino, e qui sta la bestemmia che mi permetto – il disagio delle nostre vite.
Oggetti: una sigaretta, un cellulare, una pistola, una stecca da biliardo (“è una Amoi da 1000 yuan!”), che tagliano la carne di una Cina mai vista in un set così urbano-irreale.
Parole: una lite, un disvelamento, una rissa, un invito al viaggio, che rimarginano i lembi di questa operazione a cuore aperto. Nella speranza che il paziente, e lo spettatore con lui, sopravviva. Hu Bo, come sappiamo, non v’è riuscito. La sua anima sta ancora lì, in due frammenti nascosti. Il primo, quando pedina l’anziano che cerca i proprietari del cane che ha azzannato ed ucciso il suo fedele quadrupede. Vediamo il lembo di plastica azzurro messo sul vetro dell’ascensore perché lui e la sua fedele camera a mano non appaiano. Poi e ancora, quando lo stesso attore passa in rassegna (“Voglio solo dare un’occhiata”, dice all’inserviente), le stanze della casa di riposo cui, sembra tutti vogliano destinarlo. E’ il lager del passaggio del tempo, è la cognizione dell’esistenza umana e la sua incomprensibile prigionia. Sull’ultima porta, sul vetro di quell’ultima stanza, mentre un disperato va avanti ed indietro senza soluzione di senso, vediamo la spia rossa di Hu Bo che riprende. Filma, concepisce, capisce. Il barrito finale dell’elefante è l’ultimo pensiero che la notte, il film, il regista, l’artista, il cinese, l’uomo vogliono lasciarci.
Perché suppongo ci sia una quota di profezia in quello che qui viene montato davanti ai nostri occhi, qualcosa che il ‘tecnico del media’, non solo dice ai cinesi ma che forse vuole donare a chi cinese non è. Ogni espansione è promessa di paranoia. In ogni progresso c’è scissione, in ogni forma di sviluppo c’è proiezione della sconfitta, in ogni avanzamento si trova già il diniego. Chi naviga è destinato al fondo del mare...
Per chi non lo avesse ancora inteso, Hu Bo è (e rimarrà) uno dei geografi più attendibili del nuovo secolo.