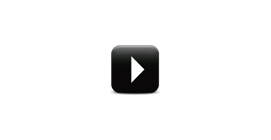"A gentle creature": il martirio dell'uomo perpetrato dall'uomo
Quello che Loznitsa compone con questo suo film, è quanto di più impersonale possa essere urlato dentro ad un’imprecazione intima e cosciente.
Quando, al giro di boa dell’opera, ci trastulliamo in disamina da Kafka a Gogol’ – quindi abbiamo repentinamente varcato quel confine visivo/letterario che, dalla solitudine angosciosa ci porta verso un grottesco che attraversa tutti gli stadi dell’emozione –, in quel sogno caramellato, insolente e patriarcale che ‘sporca’ quello che si era fin lì visto, è l’anima della protagonista (la ‘dolce creatura’ senza nome) che ci guida e non certo il disamore per il potere del portentoso regista ucraino.
Un concedere ‘libertà d’entusiasmo’, nell’interno di un film assoluto, impressionante e catacombale, che rende merito ad una narrazione che vorrebbe essere ‘russa’ (solo concepibile in un universo definito dentro all’isobara geografica), e che invece rischia di liquefarsi in ‘universale’, di spaccare l’involucro della penosa odissea urbana di una moglie in cerca della cella di suo marito, di mutarsi in sostanza ed invadere tutti gli anfratti di quel ‘muro del pianto’ che è parete di cinta dell’oppressione gerarchica. Di qualunque gerarchia, in qualsivoglia società organizzata. Un’anarchia gentile (il ‘gentle’ del titolo internazionale con cui non lo si è distribuito in Italia, ma questo va da sé), che purtroppo poca ammirazione ha generato tra il pubblico.
Ci sono varie chiavi di lettura per tentare di seguire con sagacia questo film. Una potrebbe essere, ed è la più immediata, quella del ‘ripensamento letterario’. Optare per la messa in scena di uno spunto dostoevskijano che sviluppa (avviluppa) sul rapporto tra realtà e verità. Perché è evidente che la ‘città-prigione’ in cui la moglie è costretta a trasferirsi per poter inseguire l’Autorità, ha un grado ennesimo di reale ma – e lo dice il barbone che vive raccogliendo bottiglie vuote, “Fanculo, Marx maledetto! Ha preso per il culo tutto il nostro Paese. Infame!” – è evidente che come una cipolla marcia, deve chiedere lo sforzo di penetrare soglia dopo soglia alla ricerca di oggettività. Manicomi dati alle fiamme da pazzi arsi vivi nel rogo stesso, consorti ingannate dai mariti fedifraghi e convinte di vedere ‘puttane’ da sciogliere nell’acido ovunque, madri i cui figli sono morti in guerra forse uccisi dal ‘fuoco amico’, magnaccia che sono i migliori intermediari delle alte cariche militari. Tutto trasale in una scossa di controsenso che annebbia l’animo e, allo stesso tempo, impedisce di non cercare una via di tangibilità. Cos’è vero in quel girone infernale di maceria, degrado, alcol e legge statale? E cos’è più vero del vero, tanto che si possa ripristinare una norma morale dopo ed oltre tutto l’orrore?
Altro disvelamento potrebbe essere quella di una ‘visione mitica’. Metafora di un mistero profondo, analisi di un viaggio eroico (chi è più eroe di una povera donna di campagna, che attraversa il Continente per affrontare l’Ombra, vis-à-vis?); ma è una narrazione monca. Mancano molte parti, e se è naturale che non si poteva chiedere a Loznitsa di consolarci con ricompense, vie del ritorno e resurrezioni, è altrettanto netto che ci sia al fondo una nota che stona ontologicamente.
Sia la ‘gentile creatura’ che il mondo d’ombra che le si apparecchia dinnanzi, paiono correre lungo lo stesso filo d’orizzonte. Sono elementi che arriveranno ad un punto di contatto. Si scontreranno (lo sturpo di gruppo sul cellulare militare, preconizza questo?), o magari si riconcilieranno (l’indirizzo dell’Ufficio per i Diritti Umani è in via Lenin all’angolo con via Engels, stesso luogo dove un racconto ascoltato sull’autobus teorizzava l’omicidio fatto da un killer seriale; e se quel criminale si chiama Zinka, Zinka si chiama la donna grassa che le offre vitto, alloggio e soluzione finale al mistero). Questo non viene dato sapere. Il film, tessuto con sublimi piani di ripresa, intarsiato da invenzioni fenomenali (la volante della polizia ferma al passaggio a livello; in primo piano i due poliziotti, tra l’arrogante ed il convenevole, che cercano di far desistere la donna; lei che la si vede – ieratica, apocalittica – riflessa sullo specchietto retrovisore; davanti al parabrezza il pestaggio senza motivi apparenti di un uomo; tu, spettatore, ti accorgi a scatti dei quattro livelli dell’inquadratura, abitacolo, specchietto, parabrezza, binario), riesce a portare in alto ed in basso, dentro e fuori, per quasi 150 minuti senza cedimenti decisivi. E finisce lì dove doveva finire. In una sala d’attesa della stazione, dove tutti s’addormentano e nessuno vede andar via la nostra eroina. Degna pittura alla Van Gogh dei diseredati. Da “Overture Columbus” di Sciostakovic. Rigo perfetto di A.L. Huxley. Offerta votiva ad un Bela Tarr. Una scena bellissima, che vale intere carriere di autori cinematografici, e che scalza l’azione/tempo per ottenere una sospensione nel tempo dell’azione.
Ma qui nulla c’è di cinema estatico, di avvitamento nella forma. E’ una pausa-coazione che ci spinge, ancora una volta ed in maniera probabilmente più subdola, verso un nuovo livello di sofferenza. Alla sostanza della vita. Ad ogni perenne martirio dell’uomo perpetrato dall’uomo.
Per me sono cinque stelle, o barbaramente anche di più…