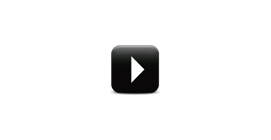“Beyond sleep” : “esperimento del come e del quando l’essere umano entra in..."
di Marco Bagarella
L’ultima volta che ho assodato quanto difficile sia non solo vivere la vita, ma anche e solo guardarla scorrere in un film, è stato sotto l’influenza ‘periodica’ (algebrica riproposizione della leggenda del ‘camminamento perpetuo’, che dai fratelli Grimm, passando per Lermontov giunge fino ad Enrico&Davide Thoreau) di quell’esperienza di ricostruzione cinematica (finzione per il pubblico) di spezzoni di rapporto reale (i tre attori in scena avevano ricevuto pochissimi dati sull’intreccio narrativo e, bontà loro, lo costruivano e decostruivano in base a flussi diretti di emozioni/deiezioni), che è “The loneliest planet”, della regista sanpietroburghese Julia Loktev.
“Non avevo dato loro che poche note, e loro dopo l’iniziale sorpresa, avevano pensato bene di passeggiare non solo dentro al paesaggio che gli si apriva davanti ogni giorno, ma proprio dentro al film!”, ha detto la Loktev in un recente incontro con la stampa.
“The loneliest planet” è stato quasi unanimemente stroncato.
E se è che il ‘mito’ – visto e considerato che sopra parlavamo di ‘leggenda’ – rappresenta la traslazione di un dogma che trascende anche la cognizione umana, il nostro confronto con quel film (impari; noi viaggiamo seduti davanti ad uno schermo di immagini bidimensionali, la Loktev, Garcia Bernal, la Furstenberg, Bizina Gujabidze ed il grande Inti Briones, attraversavano un mondo di stimolazioni tridimensionali, per non dire anche ‘extra-sensoriali’) è necessariamente sfasato. Ontologicamente. Come può aiutarci a capire noi stessi, e per analogia pure quella parte del nostro io nascosto, un’opera cinematografica che detrae dal montaggio spaziotemporale di una storia narrata, la narrazione stessa?
Ho introdotto la mia modestissima idea – di spettatore autodidatta e vergognosamente pigro – su quest’operina mastodontica di Koole, parlando della fatica ‘a togliere’ della Loktev, perché queste due produzioni sono tanto simili quanto dissimili in forma e contenuto. Ma ci aiutano a capire, sospendendosi e accumulandosi l’una nell’altra, ciò che i due registi hanno voluto comprendere, prima ancora che comunicarci. Che, cioè, la natura ha delle leggi ma che queste leggi non sono tutelate da altre leggi. Sono universi ambientali in cui tutto è dato accadere, in cui tutto accade anche non accadendo.
Se “The loneliest planet” inocula questa erudizione epidermica nella carne viva della lotta per la supremazia intellettiva ed emozionale dei due protagonisti, “Beyond sleep” la scioglie in una provetta di laboratorio dove sopra sta scritto: “Esperimento del come e del quando l’essere umano entra in competizione con il cosmo intero”.
Santi numi, ma di cosa diavolo voglio parlarvi!
Passano le prima immagini e lo spettatore pensa di trovarsi davanti al solito film d’avventura. Ma c’è un ‘ma’. Buona parte delle condizioni iniziali che i personaggi (e noi ‘con’ i personaggi), suppongono di conoscere di tutto quello che è fisicamente ri-conoscibile della terra che stanno attraversando, sono così strapiene di informazioni che non è possibile trasformarle in ‘sapere’. Non è pensabile verificare, decodificare ed utilizzare ‘pro domo nostra’, ogni singolo squarcio di paesaggio, ogni singola pietra, ogni singolo lago meteorico, ogni singolo movimento dell’ago magnetico. Ogni singolo nostro passo.
Alfred, il protagonista, un giovane studente olandese in trasferta sulle meravigliose ed inospitali montagne di Araldo Bellachioma, inizia a processare i passi. Li conta, li addozzina, li associa a numerologie (in)esatte ed a conciliazioni scientifiche. Tanto che lo spettatore, curioso fattosi nel frattempo, corregge la sua prima impressione. Forse sta guardando una commedia grottesca. Dove il semi-comico annuisce al post-esistenziale. Boh!
In un pugno (interminabile) di minuti, però, passiamo dal microstato dell’umorismo involontario a quello della lotta per la sopravvivenza. Alfred arranca, respira malamente. Sempre dietro al trio che lo precede, e che dimostra di ‘governare’ quel mondo in maniera molto più profana di lui (il suo compagno di tenda, Arne, gli spiega che forse il senso della sua esistenza è solo quello di essere lì e di nutrire col suo sangue una nidiata di fastidiosissime zanzare d’altura; durante una pausa caffè, davanti ad un panorama incredibile, da paradiso terrestre, gli viene urlata in faccia che – magari – la Creazione, quella con la ‘c’ maiuscola, è solo una fottutissima cospirazione). Cosa gli rimane da fare, nell’intento di sopravvivere al giuoco? Nient’altro che starci al giuoco. Essere allontanato sempre più da qualsiasi riferimento geografico, venire derubato di alcune foto aeree, spinto ad attraversare 36 (diconsi, 36) corsi d’acqua sempre più inviperiti di schiume e gorghi perlacei, essere abbandonato alle prese con le sabbie fangose mobili. Infine, misteriosamente, lasciato in compagnia di Arne, del suo sorriso indecifrabile e della sua amichevole antinomia.
E l’incredulo spettatore, oramai scomodo sul divanuccio di casa sua, inizia a prospettarsi una congiura, magari la macchinazione da trekking di una setta satanico-hipster del ‘National Geographic’. Si freme. S’attende. Il thrilling, lo sanno pure i bambini loggati qui dentro, è un macrostato. Anzi, è il macrostato per eccellenza.
E giungiamo alla parte più riuscita del film. Quindici-venti minuti d’incanto, degni di essere annoverati tra le cose più preziose viste in giro nell’ultimo biennio. Shakeraggio stupido d’ordinanza: un terzo del Mohamed di “Essential killing”, un terzo dell’Hugh Glass di “Revenant”, un terzo di misticismo sulfureo (il ‘masso’ di ferro-nichel che illumina il cielo!), agitato tutto con delle sapienti anche se scolastiche scelte di regia, et voilà! Il giovane geologo Alfred è oramai solo, senza più bussola né amici di scarpinata, nel tentativo di riacchiappare il fondamento psicologico della sopravvivenza stessa, che è concetto abbastanza semplice. Non cedere al panico. Non cedere davanti alla morte silente. Più che affannarsi a cercare riparo, acqua e fuoco (elementi che la filmografia di ogni tempo ci ha fatto entrare in mente, come essenziali salvavita), deve ritornare sui suoi calcoli aritmetici, sulle sue isobare ipnotiche, tra le sottrazioni di senso alla contabilità del caos, e vagare tra neve, nebbia, sagome di faggi e incuriosite Alopex lagopus. Vaga che ti vaga, numero dopo numero, si troverà qualcosa, no?
“Diobono, allora è un mystic movie, questo!”, sussulta appena prima del rutto liberatorio, alla terza Coca ghiacciata, lo spettatore incauto. Ma la fine arriva alla fine, e questa non è la fine.
Alla fine, come in ogni film salvifico compare la bambina ‘selvaggia del bosco con lupo addomesticato al guinzaglio’, che – molto fanciullescamente e favolisticamente anche – indica la strada di casa. La resurrezione è l’ultimo esame da affrontare per il nostro protagonista, per mostrare ciò che ha imparato dalla storia appena vissuta. Alfred è come rinnovato dal sacrificio a cui ha assistito ed alla prova inequivocabile che tutto il traballante armamentario numerologico, che scolasticamente si era portato appresso, in effetti gli ha mostrato l’equiprobabilità di salvare la pellaccia in condizioni estreme. La scienza serve; utile al pari di una vecchia bussola Krantz, di una rete per pescare il pesce da divorare ancora guizzante, di un telo impermeabile per ripararsi dalla pioggia gelida. Lo vediamo, finalmente in pace con se stesso, mentre sull’autobus che lo riporta nel mondo ‘civile’, indaga (finalmente libero dal sogno misogino d’inizio-film; era forse un marker predittivo?) la dolce ingenuità di una quindicenne.
Quando l’άστεροειδής (più che il near-Earth 2017 TE5 o il 2017 TD6, a me è sembrato un cazzo di 31 Euphrosyne con prole attorno!) se la smamma, l’oramai psicotico povero spettatore tira un sospiro di sollievo e si accorge di aver rimirato, per ben 110 minuti primi, un classico b-movie nordico di fantascienza.
Film sorprendente e bello. E noiosissimo. Un’opera per le masse, adatta ai soliti pochi intimi.
Se a qualcuno può interessare, al minuto sessantanove del tracking, appare Dio in persona.
È una grossa pietra bianca.