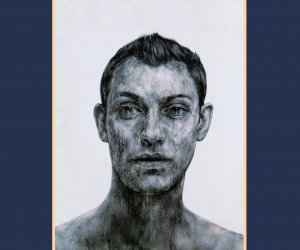Questa è la storia di uno di noi. Su "Io sono Gesù" di Giosuè Calaciura
di Marcello Benfante
Vi sono due libri in uno, in quest’ultimo lavoro di Giosuè Calaciura (“Io sono Gesù”, Sellerio). Due libri almeno, s’intende, in cui si alternano due diverse anime dell’autore.
Una prima parte di sapore più gioioso e giocoso, che corrisponde all’infanzia e alla prima giovinezza di Gesù. E poi una seconda parte, più angosciosa e pensosa, che corrisponde a una sofferta maturità e in cui appaiono i primi presagi di morte.
Se nella prima parte un Gesù picaresco esplora il mondo rutilante del circo e delle sue apparenze, delle finzioni iperboliche, dei giochi d’amore, del rischio e dell’avventura; nella seconda avviene invece un ripiegamento malinconico e disilluso: il rischio diventa disgrazia e maledizione, la solitudine condanna inesorabile.
Gesù, sempre più avvinto alla figura materna, sembra soccombere a una sindrome dell’abbandono, del tradimento, del disincanto.

Il finale si fa progressivamente più denso e più cupo. La leggerezza iniziale fa infine luogo a un pessimismo cosmico. Dal quale s’intravvede il calvario di Cristo e dell’umanità tutta.
Il personaggio pinocchiesco che era partito alla scoperta del mondo e alla ricerca del padre, come un eroe proppiano, visitando le stagioni dolci e insieme violente dell’eros sublimato, della rissa, del furto per fame, dell’incanto, della gelosia, si riduce infine a meditare sulla propria sconfitta e a considerare l’ipotesi del suicidio.
Come il Pinocchio originale, non vede per sé altra via d’uscita che il morire impiccato. Ma già una croce è apparsa nel suo destino. Lui stesso l’ha costruita, con i suoi arnesi di falegname. E già è apparsa la figura di Giuda, il traditore estremo, colui che davvero finirà impiccato, dandosi da sé, disperatamente, la morte.
Ma di questo epilogo il libro di Calaciura non fa menzione. Si arresta prima, sulla soglia del mistero supremo. Sappiamo solo che Gesù muoverà incontro al cugino Giovanni che sulle rive del Giordano sta organizzando una sorta di rivoluzione spirituale, una sorta di movimento hippie ante litteram, una rinascita e una purificazione che, per contrappeso, esigono un martirio, una vittima sacrificale.
Altro il romanzo non ci dice (e già questo dobbiamo piuttosto intuirlo che apprenderlo dalla voce narrante di Gesù). Altri romanzi, altri vangeli, daranno dei fatti postremi di Gesù, della sua agonia, la loro versione, più o meno degna di fede.
Fermiamoci quindi a questo Gesù di Calaciura, umano, fin troppo umano, nella sua mancanza di fiducia nei padri e nella vita. Un Gesù scettico, perfino ateo, che non porge l’altra guancia, che non sa fare miracoli, non risana cicatrici, che non sa trasformare le lacrime in acqua potabile, non sa resuscitare la sua fedele asina stroncata dagli stenti e dalla vecchiaia.
Il racconto di Calaciura evolve come una giornata. Se la prima parte ha lo splendore favoloso del mattino, mano a mano che procediamo verso quella che abbiamo indicato come la seconda parte, le ombre si fanno più estese e più tetre, per poi infine divenire tenebre, notte profonda e sconsolata.
Per cui vi si susseguono la fiaba, con le sue prove eroiche, i suoi incanti, le sue ricerche, le sue estroversioni e le sue divagazioni; il racconto popolare e gotico, con i suoi misteri, i suoi dilemmi, i suoi conflitti (l’assalto inesplicabile degli armigeri e quello rabbioso de cani neri); infine il dramma (l’orfanezza, la solitudine, la siccità, l’ossessione suicida).
Proprio nel dramma finale confluiscono, come in un imbuto, i temi portanti di tutto il racconto: l’assenza del padre (in cui echeggia l’ultimo grido, l’Eloì, lemà sabactani, di Cristo morente), l’autolesionismo di Gesù, la follia dell’amore impossibile, il tralignamento dei rapporti umani, l’abbrutimento di Barabba (da Mangiafuoco a Caronte), il rivelarsi osceno della bellissima Delia (dama e velata e fatina turchese che reca in sé una sordida sensualità), l’incrudelire spietato dei Romani, l’inesorabile sgretolarsi della comunità nazarena.
Fin dalla nascita Gesù si è rivelato più un portatore di disgrazie (il pastore sciancato che perde il gregge e la moglie) che il latore di una salvifica e buona novella.
Come vogliono le più antiche superstizioni, la notte della cometa annuncia sciagure, predice disastri. Gesù stesso, sebbene amato dai genitori, porterà sempre il fardello oneroso delle sue intime tribolazioni.
Il racconto che di tali tormenti dell’anima e del corpo fa Calaciura sembra procedere nelle forme classiche di una trama lineare, ma si rivela infine un labirinto in cui si gira sempre intorno a un punto (davvero cruciale). Ossia alla sconfitta ineluttabile dell’uomo, come di ogni creatura vivente.
Nel ciclo naturale, inesorabilmente, si è prede o predatori, di volta in volta vittime o carnefici, in una lotta perenne e alterna per la sopravvivenza. Né pare esservi altra sorte possibile che l’aut-aut dell’Adelchi manzoniano di “far torto o patirlo”. Così è inciso, almeno, negli atavici graffiti rupestri, nelle grotte primordiali in cui Gesù si reca a raccogliere stille d’acqua per sopravvivere al castigo della siccità (che è l’esatto opposto del diluvio universale).
A meno che l’agnello di Dio, con il suo sacrificio, non redima tutto il creato. Ma questo è un mistero di fede, super-narrativo, che l’uomo Gesù, con i suoi limiti e le sue fragilità, non potrà, naturalmente, mai raccontarci in prima persona.