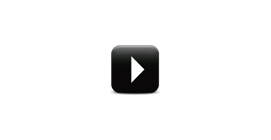Mauro Rostagno, tra Sicilia e dignità
di Claudio Fava -
Mauro Rostagno lo conobbi così, trent’anni fa. Barba, il panama in testa, il mezzo toscano spento, una faccia larga e allegra su cui s’aprivano sorrisi che sembravano incisi con il bulino. Il suo ragionamento era inappuntabile: io c’ero nato in Sicilia, me l’ero trovata addosso come un destino; lui l’aveva scelta. Per cui era più siciliano di me.
Ricordo una giornata di nuvole asciutte e di vecchi mulini con le pale ferme, e di molte fotografie con Rostagno a braccia spalancate davanti alle saline. Una di quelle giornate in cui perfino Trapani, che s’incunea tra due mari come una scialuppa, può sembrarti bella. Lo ammazzarono un paio di mesi dopo. Agguato militare e chirurgico, fucili e pistole, lasciando illesa la ragazza della comunità che era in macchina con lui.
No, ricordo male… Mauro Rostagno l’avevo conosciuto prima di quel mattino di nuvole e mare. L’avevo incontrato per caso. Uno di quei casi che però svelano e dicono, senza ricorrere a troppe parole.
Mi avevano citato come testimone in un processo in Corte d’Assise a Trapani per l’omicidio del sindaco di Castelvetrano, Vito Lipari. Il sindaco, potente democristiano della zona, l’avevano ammazzato a fucilate alle porte del suo paese e poi se n’erano andati per i fatti loro. Il caso volle che a un posto di blocco dei carabinieri fermassero un’auto con tre figurini a bordo: Nitto Santapaola, Mariano Agate e Franco Romeo. Pezzi da novanta di Cosa Nostra anche se, in quei giorni, graziosamente a piede libero per le presbiopie delle locali Procure della Repubblica. Li portano in caserma, guanto di paraffina: positivo. I tre picciotti hanno sparato. E loro confermano, sissignore signor capitano, abbiamo sparato. Alle quaglie, però. Una battuta di caccia nelle terre dell’eccellentissimo cavaliere del lavoro Gaetano Graci, padrone delle banche di mezza Sicilia. Il capitano telefona e il cavaliere conferma: a caccia con me erano…
In un paese civile, un alibi di questo tipo regge un quarto d’ora. Non a Trapani, non in quegli anni. Tante scuse a Santapaola e soci che vengono scarcerati. Per rendersi latitanti un istante dopo. Quando dalla Procura di Trapani firmeranno un mandato di cattura, dei tre nessuna traccia. In cambio, il capitano dei carabinieri (pensate le coincidenze della vita) s’era dimesso dall’Arma e l’avevano assunto come direttore nella filiale della Banca Industriale di Trapani. Dimenticavo: girava con una Renault nuova di zecca, regalata dalla concessionaria d’auto di Santapaola. Così, per amicizia…
Queste cose le avevamo scritte su I Siciliani (mentre gli altri giornali dell’isola si dedicavano all’uncinetto) e così mi avevano chiamato a testimoniare al processo. Al quale non c’era nessuno. Gli imputati contumaci. La parte civile assente. I giornalisti letteralmente evaporati: né agenzie né corrispondenti né tivù locali. Eppure era un processo perfetto come un teorema per raccontare cosa fosse davvero la mafia, un intarsio efficacissimo di violenza, impunità, protezione, collusione, denari, complicità istituzionali e affaristiche. In quell’aula di Corte d’Assise, vuota come una chiesa sconsacrata, c’era solo una telecamera, e un ragazzetto vestito di bianco che riprendeva ogni cosa. L’aveva mandata Rostagno dalla sua televisione, Rtc. Era il suo modo – semplice, essenziale, micidiale – di fare giornalismo: raccontare i fatti. Che in una città come Trapani (o come Palermo, o come Catania) non dovevi nemmeno andarteli a cercare: ti arrivavano addosso, ti travolgevano. A te, cronista, bastava infilare un foglio nel rullo della Olivetti e cominciare a scrivere il pezzo. Come facevano a I Siciliani. Come faceva Rostagno.
Lo hanno ammazzato per questo. Perché faceva il giornalista. Perché faceva bene il giornalista in un tempo e in una terra di anime silenziose, di colleghi distratti, di schiene piegate a gomito per riverire con il loro silenzio ogni manigoldo e ogni potente che attraversavano la via. Lo ammazzano perché in una città votata all’obbedienza del silenzio, Rostagno parlava. Non urlava: diceva. Le piccole cose miserabili che nessuno aveva più voglia di notare. Le logge massoniche che s’erano impadronite della vita civile di Trapani. La politica ridotta a zerbino per gli interessi di pochi padroni. Le banche che nascevano come funghi e come tumori moltiplicavano i loro sportelli, che va bene se sei a Detroit, va male se stai a Trapani che risultava l’ultima città d’Italia per reddito pro capite e allora ti veniva il sospetto che quelle banche servissero a ripulire, smacchiare, candeggiare…
Trascorremmo un giorno assieme, io e Rostagno, nella sua televisione. Piccola come una casa di marzapane ma cazzutissima perché i ragazzi, quasi tutti in libera uscita dalla comunità Saman, si divertivano molto a fare i giornalisti in quel modo. Ogni giorno una notizia, ogni giorno un “buco” alle pagine locali degli altri giornali che tra massoneria e uncinetto s’è capito cosa preferivano raccontare. Lo rividi un mese dopo per fargli una lunga intervista che fu una chiacchierata a spasso fra moli, barche, mulini, come in una tela di Gauguin. Fu allora che mi disse che era più siciliano di me. Veniva da altri mondi, da storie spezzate, da risate e battaglie epiche, ed era finito lì, in Sicilia. A occuparsi di ragazzi con la scimmia sulle spalle e di mafia. Gli chiesi: che c’entra con l’immaginazione al potere? Sono la stessa cosa, mi spiegò. “Vedi, agli uomini capita di mettere radici, e poi il tronco, i rami, le foglie… quando tira vento, i rami si possono spaccare, le foglie vengono strappate via: allora decidi di non rischiare, di non sfidare il vento. Ti poti, diventi un alberello tranquillo, pochi rami, poche foglie, appena l’indispensabile… Oppure te ne fotti. Cresci e ti allarghi. Vivi… Ecco, la mafia è negazione d’una parola un po’ borghese: la dignità dell’uomo! Io voglio avere la possibilità di guardare una persona negli occhi e dirgli di sì o di no con la stessa intensità. E la mafia questo non te lo consente”.
Ora, di Rostagno possiamo conservare il sapore di queste parole, pensare che sono trascorsi ormai trent’anni, ricordarlo e riverirne la memoria e tutto finisce lì, un altro che aveva visto lungo e giusto, e che è morto per questo. Oppure possiamo dirci che quella lezione di giornalismo (la telecamera piantata al centro di un’aula della Corte d’Assise) è disperatamente attuale. Che quell’idea di giornalismo è ancora raminga, e non solo in Sicilia. Che trent’anni dopo, quando in Italia sequestrano per mafia (per la prima volta!) un quotidiano, non si sente un fiato, non un pensiero, solo la cortesia di un prezioso silenzio affinché la gente continui a non sapere, a non capire, a non chiedere.
Alla fine, se una lezione (parola sbagliata, ma il senso è chiaro…) ci arriva da Mauro Rostagno, non dalla sua morte ma dalla sua vita, è quest’idea di giornalismo come un mestiere normale. Normale, non neutrale. Capace di stare dentro le cose che accadono, di guardarle in faccia e di raccontarle. È per questo che è morto, Rostagno. Perché fra tutti i peccati capitali, per Cosa Nostra e i suoi innominabili amici, la dignità dell’uomo è il più grave. E Mauro Rostagno, che da Trento, Milano e l’India decise poi di venire a poggiare le proprie ossa e il proprio sorriso mansueto in Sicilia, fu anzitutto un uomo ricco di dignità.
Il Fatto Quotidiano - 4 Ottobre 2018